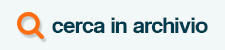Il Viaggiatore Indigeno e la città pulsante
10-07-2006 / A parer mio
di Riccardo Roversi
Il tessuto medievale di Ferrara era un tempo percorso da tre contrade: via Ripagrande, via Sabbioni e via Volte, quest'ultima si divide oggigiorno in tre parti: via Coperta, via delle Volte e via Capo delle Volte. Il tetto ad archi di quella centrale tutela l'enigma e l'aura popolare: quieta ipocondria del forese oltremura e riparo di idee e d'individui inadeguati alla luce del sole, senza anelare una peculiarità già ammansita nell'ozio e consapevole di essere talvolta ignorata, così come ignoriamo il sosia interiore quando e perché ci sgomenta.
Il percorso del nostro Viaggiatore Indigeno continua, alla (ri)scoperta della città "emozionale" più che della città architettonica, della città "pulsante" più che della città storica. Con la consapevolezza che Ferrara è un mistero, che forse è un animale fantastico addormentato entro i confini delle Mura: uno strano animale degno del "Manuale di zoologia fantastica" di Borges, un essere millenario che sogna senza smettere mai e i suoi sogni si materializzano ininterrottamente attorno agli abitanti del posto, condizionandone l'esistenza, costringendoli a fare i conti quotidianamente con l'irrealtà dei muri e delle strade, delle piazze... dei chiostri. Ne è limpida testimonianza un altro passo dell'immaginifico diario del Viaggiatore Indigeno, il quale narra di un'esperienza mistica vissuta in uno dei molti luoghi atemporali di Ferrara. Così si legge nel suo incredibile racconto.
«Faceva troppo caldo quel primo meriggio di mezzo aprile. Le torri del Castello galleggiavano leggere sull'acqua del fossato, come i quattro pezzi degli scacchi riflessi in uno specchio: gli avancorpi sbucavano da quelle maggiori quasi potessero clonarsi a piacimento, moltiplicando loro stesse all'infinito. Non mi stupirebbe affatto trovare un mattino un altro castello in qualche posto, poiché suo scopo è il medesimo da seicento anni: dominare. Egli non soggioga la città né plagia gli abitanti, semplicemente incombe, prodigandosi talvolta con le nebbie all'unico languore: quello di sparire, chissà se solo agli occhi o per davvero, amnistiandoci liberi ma contemporaneamente vulnerabili. Credo che se fosse un volto non ci donerebbe mai un sorriso.
Ciondolato un po' al serraglio dei turchi, dal Listone presi via Mazzini, poi Saraceno, porta San Pietro, Venti Settembre, porta d'Amore, Beatrice d'Este e infine vicolo del Gambone. Nel giardino esterno del monastero di Sant'Antonio in Polesine un "don abbondio" in bicicletta mi scansò filando il portico, mansueta una "perpetua" spalancò le ante e insieme dileguarono nello scuro degli affreschi. Trasognato dai viluppi bianchi e rosa del ciliegio giapponese entrai fra i pochi banchi della chiesa: dietro l'altare c'era una grata, da cui improvviso un coro limpido di monache addolcì ogni litro d'aria. "Don abbondio" pregò per assenti astanti, incluso me incorporeo e le vidi, in ultimo, inginocchiarsi come soli veli, per poi svanire oltre gli stalli e nella loro misteriosa scelta.
Fuori la luce frantumò l'incanto. Uscendo il chiostro ancora non sapevo di incontrarvi un'anima, che un giorno si sarebbe confusa con la mia».