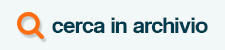La virtù non è femmina
05-07-2006 / A parer mio
di Giuliana Berengan
Il disprezzo della morte e del dolore sono, a parere di Cicerone, l'espressione massima di quella forza che, unita alla rettitudine, alla fermezza e al coraggio è segno distintivo del vir, il nome latino del maschio per nobilitare il quale fu coniata la parola virtus che ne conteneva tutti gli attributi. Dunque la natura del termine appare eminentemente ed indiscutibilmente maschile eppure la sua femminilizzazione ha radici lontane. Lo stesso Cicerone nella sua opera Sulla natura degli dei diede inizio al processo personificando la virtù in una dea, ma fu il Cristianesimo a manipolare decisamente il gene della parola al punto di farne un sinonimo di quella purezza che significava controllo degli istinti, specie quelli di natura sessuale. Con una operazione che definirei di travestitismo linguistico la virtù è andata pia piano indossando gli abiti casti e pudichi della donna di morigerati costumi e, quanto più essa si identificava con le catene talora anche dorate che legavano le donne alla propria condizione di angeli del focolare, madri e spose esemplari, tanto più si allontanava l'origine del nome. Per una delle tante, piccole, crudeli ironie della sorte abbiamo finito per portarci addosso come onorato ed oneroso segno distintivo della nostra onorevole schiavitù una parola nata per sintetizzare tutto il bello della virilità. Gli Umanisti tentarono di restituire alla virtù la sua originaria impronta di temprato coraggio, ma, forse in conseguenza della crescente perdita di eroi ed eroismi, gli uomini hanno iniziato ad abbandonare decisamente la virtù per diventare depositari del valore, un termine che pare spostarsi sempre più dall'area semantica della forza a quella del peso sociale, del potere direi quasi monetizzabile in termini di ruolo riconosciuto e come tale meritevole di ricompensa e considerazione. E così il viril sesso ci ha fatto omaggio della virtù che, come si sa, non ha prezzo, non si ostenta, è sempre pronta a darsi con sacrificio e abnegazione e si è preso il valore, meno impegnativo sul piano dei requisiti richiesti ma più facile e redditizio come merce di scambio. La storia, anche quella delle parole, ha obbedito al punto di vista dominante riconoscendo un peso sempre più rilevante ai valori e togliendo spazio alla virtù, spazio linguistico ben si intende, perché si sa che nel cuore dei benpensanti c'è sempre un posto per le donne virtuose. E vogliamo ancora credere che una manciata di "quote rosa" possa essere sufficiente a contrastare il potere di chi ha rinunciato alla virilità pur di tenerci virtuosamente senza valore? Proprio non direi. Ho piuttosto in mente un'altra via da percorrere a parziale risarcimento del pasticcio semantico che ci ha penalizzato per secoli. Propongo uno scambio di parole: restituiamo ai maschi la virtù e ci prendiamo il virtuale che ha la stessa radice anche se nessuno pare essersene accorto. Le donne sono abituate da tempo immemorabile a costruire mondi immaginari per sfuggire alle recinzioni della loro quotidianità, a sognare vite mai vissute, ad attraversare esistenze parallele nelle quali realtà e fantasia si mischiano secondo alchimie alle quali può accedere soltanto chi ha il potere della vita. Allora il viaggio virtuale è un modo per liberarci dalle presunte virtù, per avere libero accesso a ciò che un tempo era impensabile e proibito. La molteplicità di incontri, rapporti, relazioni si amplia a dismisura, fa vacillare le visioni "monocratiche". E' più facile sottrarsi ai limiti imposti da ogni forma di moralismo e bigottismo. Ora sappiamo che la virtù non è femmina ma che il virtuale può diventarlo e questa volta il gioco, e non solo quello linguistico, potrebbero essere le donne a condurlo.